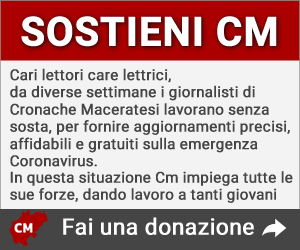Per la rinascita dell’Appennino
non servono grandi opere
ma riscoprire la sua ricchezza secolare
IL VOLUME del professore Augusto Ciuffetti ricostruisce la storia della “terra di mezzo” dall’area tosco-emiliana all’Abruzzo. No a grandi progetti economici e sociali. Si al “turismo lento”, a prodotti di eccellenza e alla tutela del paesaggio


Ugo Bellesi
di Ugo Bellesi
Il disastroso evento sismico del 2016 che ha provocato tante vittime e sconvolto un vasto arco dei nostri Sibillini ha avuto come unico risvolto positivo quello di richiamare l’attenzione di tutta Italia, attraverso i mass media, su di un territorio bellissimo e su di una eroica popolazione che per anni erano stati quasi emarginati. Infatti mentre i tanti progetti di rilancio proposti dagli enti locali sono stati sempre accantonati, e alcune delle leggi positive, che pure erano state varate da diversi Governi nazionali, o avevano scarsi finanziamenti o non sono state accompagnate dai necessari regolamenti di attuazione.
Il risveglio dell’attenzione di tutti verso quel “territorio di mezzo” ha provocato una serie di pubblicazioni, come libri e riviste, tutte interessanti e con illuminanti progetti per la rinascita di una parte d’Italia che può ancora dare un valido contributo alla crescita del Pil e alla diminuzione dello spread. Tra i tanti libri apparsi in tempi più recenti non si può fare a meno di leggere quello a firma del prof. Augusto Ciuffetti, docente all’Università politecnica delle Marche, intitolato “Appennino – Economie, culture e spazi sociali dal medioevo all’età contemporanea”, che ha il merito, prima di arrivare all’attualità, di tracciare la storia della “dorsale appenninica dell’Italia centrale, dall’area tosco-emiliana fino all’Abruzzo”. E siccome la “storia è maestra di vita” in questa narrazione, fatta in modo scientifico con precise citazioni e tantissimi riferimenti bibliografici, abbiamo tutti tantissimo da imparare.

Augusto Ciuffetti
E’ proprio in questa “terra di mezzo” che è nata la civiltà appenninica la quale ha lasciato un’impronta indelebile, confermata dal legame profondo che c’è tra gli abitanti dell’Appennino e la loro terra come dimostrano la forte resilienza di questa gente e il fenomeno ricorrente del “ritorno”. Il prof. Ciuffetti nella sua ricostruzione storica parte da lontano risalendo alla Valle Castoriana e all’abbazia di Sant’Eutizio (“la più antica prosa lunga in volgare proviene proprio da quel monastero”). Il che gli consente di sottolineare “l’alto tasso di alfabetizzazione nelle aree montane” nonché “la diffusione di una cultura popolare di grande valore e rilievo” oltre alla presenza “nel territorio di un patrimonio artistico di rilievo”. E conclude affermando che si tratta di “una civiltà appenninica in grado di illuminare per l’intera età moderna l’Italia centrale” (come rivela in una intervista rilasciata alla redazione di “Letture.Org”). Tanto è vero che il primo libro stampato in Italia proviene da una prototipografia installata all’interno del monastero di Santa Scolastica a Subiaco. E la cultura viaggia anche grazie all’industria cartaria e grazie ai traffici commerciali che legavano il porto di Ancona, attraverso l’Appennino, all’Abruzzo e al Lazio. E ovviamente egli fa riferimento anche al francescanesimo e alle numerose comunità religiose sparse in questo territorio.
Passando ad esaminare la situazione economica il prof.Ciuffetti spiega che la gente “riusciva a sopravvivere integrando la coltivazione di piccoli appezzamenti di terra con la pratica degli usi civici e partecipando alla gestione e allo sfruttamento di beni comuni o collettivi”. Ed era intenso un circuito commerciale tra “terre alte” e “terre basse” con un capillare sistema di tratturi, sentieri e mulattiere. Altro fenomeno era costituito dal fatto che i contadini avevano una pluriattività ricorrendo anche alla migrazione stagionale, che caratterizzava non solo la transumanza delle greggi ma anche quanti, oltre a coltivare i campi, diventavano carbonai, fornaciai, braccianti, venditori ambulanti nella maremma o nell’agro romano. Per non parlare delle protoindustrie come mulini, gualcherie, cartiere, concerie, segherie, lanifici che servivano non soltanto i mercati locali ma anche quelli lontani. E queste attività erano favorite dal fatto che la forza motrice era fornita dai corsi d’acqua.
Il prof. Ciuffetti passa infine ad esaminare le prospettive di rinascita di questo territorio ed esclude subito la possibilità di attuare grandi progetti economici e sociali che non sono applicabili all’Appennino. E’ invece importante puntare alla riscoperta dei “beni territoriali” pensando soprattutto ad un turismo delle aree interne “a passo lento” favorito dalla sentieristica. Ma questo va integrato con una produzione agricola che privilegi la biodiversità, preziosa per proteggere il paesaggio. Bisogna soprattutto pensare ad una produzione di alta qualità che abbia l’impronta della tipicità e del marchio che avvalori l’appartenenza a quel territorio. I consumatori infatti sono sempre più alla ricerca di cibi genuini e garantiti. Anche i processi produttivi però dovrebbero essere “artigianali” quindi “esclusivi per quanto possibile del territorio” dal momento che quelli industriali li troviamo in tutto il mondo.
Passando alle conclusioni l’autore evidenzia come, per attivare tutto ciò, sia necessario un “contenitore politico”, con relativi strumenti amministrativi e normativi, che consentano di portare avanti questi progetti e queste idee. Poi per gestire le risorse collettive e per durare nel tempo egli propone, quale ente territoriale, le “Comunanze agrarie”, bisognose però di un aggiornamento mediante “cooperative di comunità” che consentano ai montanari (vecchi e nuovi) di rimanere nel territorio e di sviluppare progetti economici, sociali e culturali. Solo in questo modo l’Appennino può tornare ad essere “uno spazio accogliente e aperto nei confronti degli ‘altri’, dove regnino coesione sociale e solidarietà, indispensabili per ritrovare lo spirito di umanità “che appartiene alla storia plurisecolare della dorsale appenninica”.
Articoli correlati
Torna alla home page
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
- 20:45 - Lavoratori interinali senza stipendio:
«La Tempus ha promesso di pagare maggio» - 20:24 - Marco Monaldi saluta la Serie A:
«Il mio futuro al Var» - 20:05 - Trovato con 130 grammi di cocaina:
il 34enne va in carcere - 19:56 - Lite per gelosia,
botte fra due ragazzine - 19:52 - Porto ancora senza un progetto:
«Tanti annunci, ma siamo in alto mare» - 19:16 - Nuvole (festival) sopra i Monti Azzurri:
viaggio culturale tra i borghi e il cielo - 18:30 - Buona la quarta, c'è il numero legale.
Riecco Nuova Via Trento:
debito fuori bilancio da 2,4 milioni - 18:25 - «Non solo Corneto senza autobus:
tagli anche alle linee 5 e 6,
l'amministrazione ci ripensi» - 18:07 - Operaio ferito alle gambe,
interviene l'eliambulanza - 17:48 - Casa studenti anziani
e bilancio dei Teatri in Consiglio - 16:36 - Una mostra da gustare
con gli occhi e con le orecchie - 16:04 - «Bandiera gialla, il Pd vive di livore
e pregiudizio per l'amministrazione» - 15:56 - «Un clima unico avvolge il borgo,
più di 400 persone coinvolte»
Tutto pronto per il Palio dei Terzieri - 15:44 - Si schianta contro la centralina:
fugge ma lascia la targa - 15:36 - Unimc gioca a padel
- 15:15 - Lavori post sisma:
cambia la viabilità in centro
dal 14 al 16 luglio - 14:50 - Cocaina nel borsello,
36enne arrestato a Macerata - 14:25 - Carabinieri tra turni massacranti
e carenza di organico:
«Situazione non più tollerabile» - 14:20 - Agostini: «Le Marche terra di cinema,
chi lo avrebbe detto?»
A Recanati prima assoluta del film con Whoopi Goldberg ( Video) - 14:14 - Tensostruttura della scuola di via Tacito,
lavori per 120mila euro
-
25 Giu -
Madre di due figlie muore a 42 anni
dopo una lunga malattia (187) -
2 Lug -
Matteo Ricci contro il caldo torrido:
«Un albero per ogni marchigiano» (161) -
10 Lug -
Muore a 78 anni Giuseppe Paolucci,
storico chirurgo civitanovese (136) -
30 Giu -
Nessun colpevole per Banca Marche:
tutti assolti dalla Corte d’appello (113) -
27 Giu -
Macerata città astratta:
il logo che ognuno vede a modo suo (111) -
23 Giu -
Lo chef Bedini stroncato da un malore,
una vita tra cucina e politica (99) -
8 Lug -
Costruiscono un bagno senza permessi:
denunciati i proprietari della casa (99) -
26 Giu -
Un medico sempre in prima linea,
è morta Daniela Del Bello:
«E’ stata un esempio per i colleghi» (98) -
28 Giu -
Pd, 5Stelle e altre 17 sigle
Il centrosinistra firma il programma.
Ricci: «Ci vuole un cambio di Marche» (95) -
26 Giu -
Furti a raffica in centro,
aggredita commessa di Calliope:
«Presa per le braccia e strattonata» (68) -
21 Giu -
Zfu rifinanziata, superbonus prorogato:
«Boccata d’ossigeno per il cratere» (64) -
30 Giu -
Schianto lungo la superstrada:
il motociclista è morto.
Era un istruttore d’equitazione (64) -
1 Lug -
«Un solo passeggero
sul volo Ancona-Roma» (61) -
23 Giu -
«Multa per la sosta scaduta,
la raccomandata arrivata a casa:
50 euro per 11 minuti di ritardo» (61) -
21 Giu -
Lite furiosa sul lungomare,
due donne si picchiano:
bloccate dai carabinieri (Foto) (60) -
5 Lug -
Aggredisce medico e infermiera,
arrestato un 23enne (59) -
22 Giu -
Pienone in spiaggia a Civitanova:
«C’è posto solo sopra gli ombrelloni» (Foto) (57) -
26 Giu -
Cantiere in superstrada,
ricominciano le code d’estate (55) -
4 Lug -
«Acquaroli, quando si vota?
Hanno paura della vicenda Atim
o dell’effetto dazi del loro Trump?» (53) -
3 Lug -
Rapporto Crea sulla sanità,
«Marche al 16esimo posto in Italia:
Acquaroli e Saltamartini chiedano scusa» (53)
- 14 Giu - Donna uccisa in strada a coltellate:
l’ex marito l’ha presa a calci,
poi si è seduto su una panchina - 18 Giu - Maturità, “Rispetto” la traccia più scelta:
gli studenti parlano dei femminicidi.
«Ora la paura è per la prova di domani» - 29 Giu - Schianto lungo l’Adriatica:
morto un motociclista - 2 Lug - La Provincia svuota i garage:
all’asta auto, furgoni e spargisale - 8 Lug - Follia nel centro di Tolentino:
uomo gira armato di spranga (Video) - 14 Giu - Femminicidio di Gentiana, l’amica:
«Ero al telefono con lei quando l’ha colpita»
L’ex marito fermato dai carabinieri (Il Video) - 21 Giu - Trovato morto dentro un canale,
choc a Passo di Treia - 29 Giu - Malore al parcheggio del ristorante,
morta una turista - 18 Giu - Tentano di svuotargli il conto corrente:
sventata truffa informatica - 30 Giu - Schianto lungo la superstrada:
il motociclista è morto.
Era un istruttore d’equitazione - 18 Giu - Aggredite e derubate sul lungomare,
ragazzo interviene e viene pestato:
denunciati quattro giovani - 21 Giu - Tragedia a San Severino,
40enne trovata morta in casa - 26 Giu - Furti a raffica in centro,
aggredita commessa di Calliope:
«Presa per le braccia e strattonata» - 21 Giu - Il percorso Kneipp ora ha i suoi laghetti
- 25 Giu - Nuova cabinovia, partono i lavori:
operazione da 16 milioni di euro.
Le ruspe demoliscono la seggiovia - 10 Lug - S’incatena davanti alla fabbrica:
«Non ci pagano da due mesi» - 6 Lug - Marito e moglie rischiano di annegare:
soccorsi da guardaspiaggia e bagnanti - 3 Lug - Il prof Frontoni consegna lo smartphone
alla figlia di 12 anni,
ma le fa firmare un accordo unilaterale - 5 Lug - Al lavoro lungo i binari,
arresto cardiaco: muore 51enne - 15 Giu - Gentiana accoltellata alle spalle,
le confessioni dell’ex marito:
«Era la terza volta che ci provavo»